il tuo sito di informazione musicale
![]()
THE JOHN-PAULS "Forget to remember to forget"
(2017 )
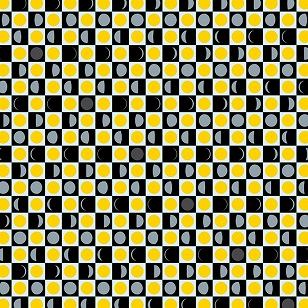 Scordatevi pure di mettere mano o orecchio alla next big thing, o semplicemente a qualche forma d’arte varia che ancora vi mancava: di fronte avete “Forget to remember to forget”, debutto vero e proprio – solo un ep di quattro tracce all’attivo finora – di The John-Pauls, quartetto di Austin, Texas: specie o sottospecie di post-qualcosa, un quarto di secolo di musica più o meno off rinchiusi in una mezz'ora che non appartiene ad alcun luogo e a tutti i luoghi, a nessun tempo e a qualsiasi istante fra il 1990 ed oggi, helzapoppin’ hippie sbracato e inconcludente à la maniera dei Pavement o chissà cos’altro.
Si alternano alla voce – un brano ciascuno, in rigorosa successione – il maschietto Philip e la femminuccia Mikila in un pastiche quasi fiabesco fatto di ballate meste, mai violente, sempre slabbrate, come una “The house-husband stomp” costruita attorno al crescendo della voce su un impasto monocorde, improbabile jam tra Arcade Fire, Clap Your Hands Say Yeah! e pure – ma sì – il Damien Rice meno soporifero ed i Cloud Nothings più accomodanti.
Fra melodie stracciate contrappuntate da un pianoforte quasi inessenziale eppure così innegabilmente bello, come nell’insistito controtempo à la Talking Heads di “Oh shit!”, l’album resta imperniato sulla preponderanza dell’elemento ritmico e di linee tenui e slack, in un’ineludibile indolenza di fondo mai tediosa o vanesia: è un gioco innocente che tradisce scoperte ascendenze indie, come nella frase compassata che attraversa “Backwards disaster” in un chitarrismo mai affilato o nevrotico - un po’ Courtney Love addomesticata, un po’ il versante edulcorato di Corgan & soci -, un uso delle sei corde determinante nel delineare un’atmosfera di fondo ovattata, psichedelica nel senso più confortante e confortevole, molto simile (“Chuck Yeager”) alle morbide, ingannevoli divagazioni dei DIIV.
E se “Let’s burn down Westlake” potrebbe essere una outtake dai Jesus & Mary Chain di “Darklands” deviata dall’ennesima incursione slegata del piano, “Sweeden”, stralunata e velvetiana per due-accordi-due di chitarra distillata e percussioni davvero memori di Moe Tucker, abbassa il tiro per un paio di minuti prima della chiusa straniante di “I am a songbird”, ancora Reid/Reid a braccetto con una rilettura sbalestrata, sgangherata e confusa dei crismi garage, un guazzabuglio di distorsioni inoffensive che collassa su sé stesso prima di naufragare nel nulla.
In mente rimangono trame sospese e tinte pastello appena screziate da una leggera coltre di alterigia docilmente blasé, quella che riconduce a certe sonorità scomposte e casalinghe da Neutral Milk Hotel, la stessa che rende memorabili i tre minuti di “Now won”, mid-tempo caracollante fra Cure, Pains Of Being Pure At Heart e Belle And Sebastian in un gioco di specchi ed assonanze che di continuo confonde e svia.
Il resto è solo fascino, ricordo, riscoperta, un magnetismo forse non del tutto spiegabile: così vicino, così lontano. (Manuel Maverna)
Scordatevi pure di mettere mano o orecchio alla next big thing, o semplicemente a qualche forma d’arte varia che ancora vi mancava: di fronte avete “Forget to remember to forget”, debutto vero e proprio – solo un ep di quattro tracce all’attivo finora – di The John-Pauls, quartetto di Austin, Texas: specie o sottospecie di post-qualcosa, un quarto di secolo di musica più o meno off rinchiusi in una mezz'ora che non appartiene ad alcun luogo e a tutti i luoghi, a nessun tempo e a qualsiasi istante fra il 1990 ed oggi, helzapoppin’ hippie sbracato e inconcludente à la maniera dei Pavement o chissà cos’altro.
Si alternano alla voce – un brano ciascuno, in rigorosa successione – il maschietto Philip e la femminuccia Mikila in un pastiche quasi fiabesco fatto di ballate meste, mai violente, sempre slabbrate, come una “The house-husband stomp” costruita attorno al crescendo della voce su un impasto monocorde, improbabile jam tra Arcade Fire, Clap Your Hands Say Yeah! e pure – ma sì – il Damien Rice meno soporifero ed i Cloud Nothings più accomodanti.
Fra melodie stracciate contrappuntate da un pianoforte quasi inessenziale eppure così innegabilmente bello, come nell’insistito controtempo à la Talking Heads di “Oh shit!”, l’album resta imperniato sulla preponderanza dell’elemento ritmico e di linee tenui e slack, in un’ineludibile indolenza di fondo mai tediosa o vanesia: è un gioco innocente che tradisce scoperte ascendenze indie, come nella frase compassata che attraversa “Backwards disaster” in un chitarrismo mai affilato o nevrotico - un po’ Courtney Love addomesticata, un po’ il versante edulcorato di Corgan & soci -, un uso delle sei corde determinante nel delineare un’atmosfera di fondo ovattata, psichedelica nel senso più confortante e confortevole, molto simile (“Chuck Yeager”) alle morbide, ingannevoli divagazioni dei DIIV.
E se “Let’s burn down Westlake” potrebbe essere una outtake dai Jesus & Mary Chain di “Darklands” deviata dall’ennesima incursione slegata del piano, “Sweeden”, stralunata e velvetiana per due-accordi-due di chitarra distillata e percussioni davvero memori di Moe Tucker, abbassa il tiro per un paio di minuti prima della chiusa straniante di “I am a songbird”, ancora Reid/Reid a braccetto con una rilettura sbalestrata, sgangherata e confusa dei crismi garage, un guazzabuglio di distorsioni inoffensive che collassa su sé stesso prima di naufragare nel nulla.
In mente rimangono trame sospese e tinte pastello appena screziate da una leggera coltre di alterigia docilmente blasé, quella che riconduce a certe sonorità scomposte e casalinghe da Neutral Milk Hotel, la stessa che rende memorabili i tre minuti di “Now won”, mid-tempo caracollante fra Cure, Pains Of Being Pure At Heart e Belle And Sebastian in un gioco di specchi ed assonanze che di continuo confonde e svia.
Il resto è solo fascino, ricordo, riscoperta, un magnetismo forse non del tutto spiegabile: così vicino, così lontano. (Manuel Maverna)