
JOE BATTA & I JEKO "Noi odiamo Joe Batta & i Jeko"
(2019 )
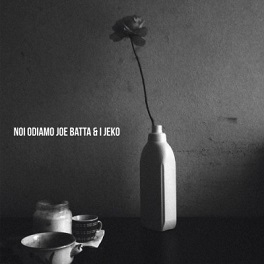 E’ inenarrabile la bislacca tenerezza che pervade questo pugno di canzoni dolenti, sofferte, beffarde.
E’ inenarrabile la bislacca tenerezza che pervade questo pugno di canzoni dolenti, sofferte, beffarde.
A porgerle - non senza sfatta eleganza - è una band cangiante originaria del teatino, oggi tre elementi che rendono collettiva una musica nata quasi per caso in perfetta solitudine eoni fa e quasi per caso riarrangiata poi ad arte per portarla in giro sui palchi. Si chiamano Joe Batta & i Jeko, tipo Doctor & The Medics o Joe Perrino & the Mellowtones, quei nomi demodé che sanno di un tempo lontano.
“Noi odiamo Joe Batta & i Jeko”, su etichetta Old Tower Records, è una piccola perla di indie vecchio stile, che la parola indie non si usa più, ma tanto la usano ancora tutti perché qualcosa vuol pur dire.
Vuol dire un suono che alcuni non capiscono, qualcosa di post, vuol dire parole un po’ sbilenche, quei testi che dicono tutto e non dicono niente nei quali puoi trovare ciò che vuoi o la negazione di ciò che vuoi.
Vuol dire che c’è la chitarra che vaga per i meandri di armonie sgangherate, vuol dire che c’è il basso che non funge da comprimario, ma al contrario disegna qualcosa in autonomia, piacevole o no che sia. In pratica: la descrizione di un attimo, o dei tre minuti de “La mia migliore amica”, fate voi.
Vuol dire che puoi cantare come ti pare, che chi se ne sbatte del bello stile vocale: Joe in persona butta lì la sua come di sdegno in una manciata di ballate truccatissime, forse pezzi partoriti in cameretta, in cantina, in spiaggia, divenuti altro tra le mani di una band che non nasce tale. Sembra un po’ Edda a tratti, o Manuel Agnelli, anche se non grida mai. Tiene tutto lì, sbavando le vocali e mangiandosi le consonanti, in un crooning che è per metà sbronzo e per metà strafatto.
E poi – bang! - rattristiamoci un po’, che è una delizia crogiolarsi tra le calde coperte di quello che i critici bravi ogni tanto chiamano spleen. Spleen albionico, se sono bravissimi. E’ quello che succede nei quattro minuti e quattro secondi di “Come tu mi vuoi”, con piccole note a disegnare una melodia che – confiteor - porta sul ciglio delle lacrime, e non aggiungo altro mentre il giro continua all’infinito. Non proprio all’infinito. Lo ripete dieci volte, ed a ciascuna virata speri di avere sbagliato i conti, e che ne segua un’altra. Ho aspettato invano l’undicesima, non è arrivata.
Ci sono tre episodi strumentali tutt’altro che inessenziali o interlocutori, c’è l’arpeggio bucolico di “Bonjour mademoiselle” che introduce una nenia di morte varia su un’aria davvero à la Afterhours di vent’anni fa (che meraviglia, per noi diversamente giovani!), ci sono i quasi sei minuti implosivi e contratti di “Vedrai, vedrai” su un’ossatura ritmica che si agita sottopelle.
Ma c’è soprattutto una “Ciao Jane” che inizia come fossero i Sacri Cuori e si trasforma in non so neppure cosa – forse i Bauhaus? - tra parolacce e una storiaccia storta in una summa di pura perfezione indie (l’ho già detto?) che insieme alla sopracitata “Come tu mi vuoi” vale tutto il disco ed anche il prossimo e quello dopo ancora.
Fra le molte cose che questo album incarna, ce n’è una che le batte tutte: in fondo, è un disco triste, di quella tristezza dalla quale ben volentieri ti dichiari prigioniero e vittima sacrificale. E’ quello che i critici bravi ogni tanto chiamano spleen. Anzi: spleen albionico.
E’ uno dei dischi più belli dell’anno, quasi per caso. (Manuel Maverna)