
NORTHWAY "Small things, true love"
(2017 )
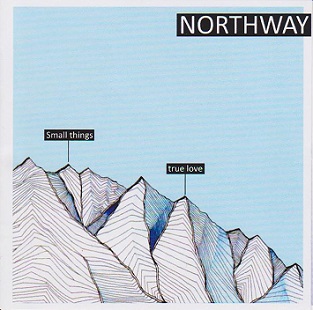 Siamo seri, bimbi belli: quello che oggi vi ostinate ad etichettare come post-rock nemmeno esisteva quando noi diversamente giovani ci lambiccavamo il cervello con il primigenio, autentico post-rock, una forma d’arte concettuale che in quella guisa originaria abbiamo visto nascere, crescere, infine morire altrettanto repentinamente come rapida era sbocciata, soffocata dalla sua stessa cervellotica natura e dall’impossibilità di aggiungere altro alle elucubrazioni colte che l’avevano partorita.
Poi - è dubbio il come ed il quando - una nuova idea si è fatta strada dopo silente vedovanza, assumendo l’identità del defunto post-rock, ma senza più attinenza con le passate vestigia: delle anticaglie post-rock dei miei vent’anni nomina nuda tenemus, non c’è nesso fra June Of ’44 e God Is An Astronaut neanche a cercarlo col lanternino, spiacenti.
Ma tagliamo corto: nel mare forse nemmeno tanto magnum del post-rock odierno - che è emotivo, non più cerebrale - ci sono i Northway, quattro ragazzi da-Bergamo-con-amore che realizzano nelle cinque lunghe tracce strumentali di “Small things, true love”, esordio autoprodotto, un piccolo capolavoro. Piccolo, forse, ma pur sempre clamoroso. Sì, perché come il punk (please please please, vedere alla voce: Razzi Totali) anche il post-rock bisogna saperlo fare: non bastano un paio di chitarre, un po’ di atmosfera, il consueto crescendo, il consueto diminuendo, la consueta reprise del tema, la consueta chiusura assordante. Al di là della tecnica e di una rispettosa propensione a non pasticciare una materia delicata che richiede eleganza ed acuta predisposizione, occorrono anche idee, qualcosa che ravvivi l’interesse per un sottogenere che soggiace sempre più di frequente al dominio di stilemi marmorizzati.
Appunto, le idee: “Arrival”, sette minuti e mezzo di biglietto da visita, apre su quella che sembra addirittura una lunga intro da Cure, cadenza cupa e ossessiva che cresce lieve e gentile alla maniera degli Explosions In The Sky (e chi, se no?) avvolta attorno ad una melodia esile, quasi timida: monolitica d’animo, ma punteggiata da minuscoli drones delle chitarre, tessiture e trame che svelano una filigrana preziosa e fitta, strati di suono sovrapposti a disegnare stasi e movimento, tensione immaginata, figurata, implosiva. E’ un sabba “The King”, scandita dal pulsare rotondo del basso su frasi psichedeliche delle chitarre, ricordano “The Dead Flag Blues” i due minuti iniziali di “The Martian” con quella voce aliena che inquieta e suggerisce, prima che una nuova desolata melodia abbia il sopravvento, ingoiata in un finale convulso à la Mogwai.
“Small things, true love” non ha vero sviluppo e forse neppure lo desidera, procede sulla medesima linea vagamente psicotica ed introversa ripetendo all’infinito la sua malìa (“The Martian” chiude proprio su un tema di chitarra à la Robert Smith, quasi nascosto nella densità del crescendo), sfiorando la trascendenza mistica e l’esoterismo degli strabilianti Saint Lawrence Verge nell’abbrivio di “Verne”, impastando tesi e antitesi negli otto minuti di “Small things”, accumulo ostinato che travalica la somma delle parti giocando a trovare il punto di contatto fra l’immobilità atonale dei seminali For Carnation ed il sovraccarico soffocante di Menuck & Amar.
In tutto ciò e nel suo contrario alberga la grandezza del progetto: mentre il post-rock di seconda generazione evoca immagini per il tramite del linguaggio musicale, i Northway muovono da scenari già definiti da decostruire idealmente à rebours. Sembra roba da niente, ma lo dicevo io che il post-rock bisogna saperlo fare: con la testa, prima che con le chitarre. (Manuel Maverna)
Siamo seri, bimbi belli: quello che oggi vi ostinate ad etichettare come post-rock nemmeno esisteva quando noi diversamente giovani ci lambiccavamo il cervello con il primigenio, autentico post-rock, una forma d’arte concettuale che in quella guisa originaria abbiamo visto nascere, crescere, infine morire altrettanto repentinamente come rapida era sbocciata, soffocata dalla sua stessa cervellotica natura e dall’impossibilità di aggiungere altro alle elucubrazioni colte che l’avevano partorita.
Poi - è dubbio il come ed il quando - una nuova idea si è fatta strada dopo silente vedovanza, assumendo l’identità del defunto post-rock, ma senza più attinenza con le passate vestigia: delle anticaglie post-rock dei miei vent’anni nomina nuda tenemus, non c’è nesso fra June Of ’44 e God Is An Astronaut neanche a cercarlo col lanternino, spiacenti.
Ma tagliamo corto: nel mare forse nemmeno tanto magnum del post-rock odierno - che è emotivo, non più cerebrale - ci sono i Northway, quattro ragazzi da-Bergamo-con-amore che realizzano nelle cinque lunghe tracce strumentali di “Small things, true love”, esordio autoprodotto, un piccolo capolavoro. Piccolo, forse, ma pur sempre clamoroso. Sì, perché come il punk (please please please, vedere alla voce: Razzi Totali) anche il post-rock bisogna saperlo fare: non bastano un paio di chitarre, un po’ di atmosfera, il consueto crescendo, il consueto diminuendo, la consueta reprise del tema, la consueta chiusura assordante. Al di là della tecnica e di una rispettosa propensione a non pasticciare una materia delicata che richiede eleganza ed acuta predisposizione, occorrono anche idee, qualcosa che ravvivi l’interesse per un sottogenere che soggiace sempre più di frequente al dominio di stilemi marmorizzati.
Appunto, le idee: “Arrival”, sette minuti e mezzo di biglietto da visita, apre su quella che sembra addirittura una lunga intro da Cure, cadenza cupa e ossessiva che cresce lieve e gentile alla maniera degli Explosions In The Sky (e chi, se no?) avvolta attorno ad una melodia esile, quasi timida: monolitica d’animo, ma punteggiata da minuscoli drones delle chitarre, tessiture e trame che svelano una filigrana preziosa e fitta, strati di suono sovrapposti a disegnare stasi e movimento, tensione immaginata, figurata, implosiva. E’ un sabba “The King”, scandita dal pulsare rotondo del basso su frasi psichedeliche delle chitarre, ricordano “The Dead Flag Blues” i due minuti iniziali di “The Martian” con quella voce aliena che inquieta e suggerisce, prima che una nuova desolata melodia abbia il sopravvento, ingoiata in un finale convulso à la Mogwai.
“Small things, true love” non ha vero sviluppo e forse neppure lo desidera, procede sulla medesima linea vagamente psicotica ed introversa ripetendo all’infinito la sua malìa (“The Martian” chiude proprio su un tema di chitarra à la Robert Smith, quasi nascosto nella densità del crescendo), sfiorando la trascendenza mistica e l’esoterismo degli strabilianti Saint Lawrence Verge nell’abbrivio di “Verne”, impastando tesi e antitesi negli otto minuti di “Small things”, accumulo ostinato che travalica la somma delle parti giocando a trovare il punto di contatto fra l’immobilità atonale dei seminali For Carnation ed il sovraccarico soffocante di Menuck & Amar.
In tutto ciò e nel suo contrario alberga la grandezza del progetto: mentre il post-rock di seconda generazione evoca immagini per il tramite del linguaggio musicale, i Northway muovono da scenari già definiti da decostruire idealmente à rebours. Sembra roba da niente, ma lo dicevo io che il post-rock bisogna saperlo fare: con la testa, prima che con le chitarre. (Manuel Maverna)