
PINK TURNS BLUE "Black swan"
(2025 )
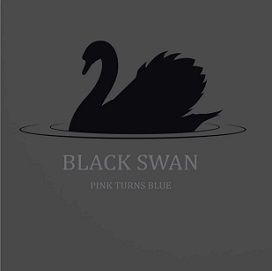 Ripeto, ribadisco e sottolineo: non ho più l’età in cui mi importa qualcosa di mode e tendenze, della next-big-thing, del sensazionalismo che circonda certe uscite, delle lodi sperticate per questo o quel clone di qualcosa che già conosco.
Ripeto, ribadisco e sottolineo: non ho più l’età in cui mi importa qualcosa di mode e tendenze, della next-big-thing, del sensazionalismo che circonda certe uscite, delle lodi sperticate per questo o quel clone di qualcosa che già conosco.
E va bene apprezzare l’estro, l’innovatività, il guizzo, il genio: ma volete mettere questi quarantanove minuti di pura beatitudine per nostalgici, anime crepuscolari, esseri sensibili latu sensu?
Poesia d’antan, niente di più, e anche questo vorrei fosse chiarissimo: anzi, cristallino.
Pink Turns Blue sono un’istituzione internazionale in ambito darkwave/post-punk: tedeschi, nati quarant’anni fa a Berlino nel pieno fulgore del gothic-rock, sono oggi un trio formato dal fondatore Mic Jogwer, voce e chitarra, unico della line-up originaria, dal bassista Luca Sammuri e dal batterista Paul Richter. “Black Swan”, su etichetta Orden Records, è il loro dodicesimo album, che nulla aggiunge né sottrae ai fasti – anche recenti – di una carriera caratterizzata da unanime riscontro ed altrettanto solido apprezzamento, vuoi dagli esordi fino allo scioglimento del 1995, vuoi dopo la reunion del 2003.
Mutatis mutandis, mi è sembrato di tornare - aspettate ad insorgere! – a quando ascoltai, ancora adolescente, ma già indirizzato, “First and last and always” dei Sisters Of Mercy: canzoni cupe e abbacchiate, dalle quali mi aspettavo chissà quali sconvolgimenti, ma che mi introdussero invece al cospetto di una musica formalmente educata, squadrata, trasognata entro i suoi confini ritmici trafitti da frasi di chitarra gentili e meste. Ecco, stessa sensazione.
Nei tre, quattro, cinque minuti di ogni traccia, la linea portante è sostanzialmente invariata: come da inveterata tradizione, manca il canonico strofa-ritornello-strofa, sostituito dall’ugualmente abituale fluire ininterrotto ed incessante di melodie afflitte, col chorus affidato ad un verso ripetuto a mo’ di anthem, spesso costituito dal titolo della canzone.
Sia che sporadicamente abbassi i giri – la ballata accorata di “Black Swan (But I Know There’s More to Life)” – sia che velocizzi il passo – il battito incalzante di “Like We All Do” - il copione non muta: undici pezzi, tutti mid-tempo, tutti in quattro quarti, tutti in minore, tutti contriti quanto basta a marcare il territorio e a definire il mood, con Mic che canta mesto e desolato, la voce blandamente filtrata, senza esagerare, senza urlare, senza piagnucolare. L’ho ascoltato in cuffia una sera mentre pulivo delle grosse cosce di pollo, e mi sono sentito così bene che l’ho pulito ancora meglio, il pollo. Ogni mio gesto – un atto qualsiasi, comune - accompagnato da una colonna sonora ideale da lasciar lievitare, un fluido benefico che ti scivola tra i pensieri, ti scorre nelle vene, si insinua sottopelle, morbidamente.
Racchiuso tra le mura accoglienti di questo disco c’è tutto ciò che serve per trovarsi al sicuro al riparo dalla tempesta: per regalarsi memorie mai sopite di tempi andati non occorre nulla più del basso rotondo e pulsante à la Peter Hook che puntella le fondamenta di “Please Don’t Ask Me Why”, dell’arpeggio sfuggente di “I Can Read Your Name in the Stars”, dell’inciso accattivante di “Dancing with Ghosts”, dei quattro- accordi-quattro (ma perfetti) di “Can’t Do Without You”.
La distanza tra l’apertura così adorabilmente retrò di “Follow Me” ed il commiato così adorabilmente retrò di “Stay for the Night” è un batter di ciglia, tre quarti d’ora o una vita, l’alba o la notte, un soffio che abbraccia e coccola la malinconia che ti porti dentro, mentre tutto intorno è solamente pioggia e Germania. (Manuel Maverna)