
biVio "Ex sync"
(2024 )
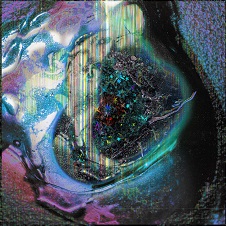 Questo disco è di una bellezza insensata.
Questo disco è di una bellezza insensata.
Fa quello che gli pare come gli pare, senza vincoli, senza porsi particolari problemi di coerenza stilistica, senza ricercare fedeltà ad una linea che nemmeno c’è, trovando anzi nel suo insistito peregrinare la ragion d’essere di cotanto fascino e fulgida brillantezza.
Ispirato e urgente, ondivago con misura, spazia in mille direzioni, zingaresco e apolide, conservando per quarantatré minuti di pura beatitudine un’eleganza raffinata e gentile, graffiante a tratti, evoluzione controllata che mai cede ad eccessi, mentre ammalia e coinvolge.
Cantato in italiano, inglese, spagnolo e francese, “Ex Sync”, statuario debutto su etichetta The Beat Production, mischia umori e idiomi, idee e suggestioni, fondendoli in un milieu intriso di un’autorevolezza che meraviglia e cattura; avvolgente e trascinante a tratti, altrove sornione e conciliante, sonda terreni vergini, si incunea in recessi nascosti, sperimenta con grazia, mai smarrendo il fil rouge di un art-rock sui generis, sfaccettato e melodioso.
Fonte del piccolo grande prodigio sono i biVio, nati come duo acustico nel 2018 dall’incontro parigino tra la cantante e violoncellista Natalia Bacalov, ultima figlia del grande Luis, ed il chitarrista francese Martin Sevrin; di lì a poco, mutano stabilmente in quartetto con il successivo ingresso in formazione del bassista argentino Homero Prodan e del batterista Lorenzo Capparucci, ciascuno dei membri recando in dote virtù peculiari, riflesse nelle trame cangianti e mutevoli di un album inafferrabile, impossibile da circoscrivere, indefinibile nel suo scintillante, luminoso, incessante movimento.
L’abbrivio di “Clessidra”, in italiano, bella eco fine anni novanta, inganna con sirene indie subito spente dalle inflessioni vagamente jazzy di “Lockdown in heaven”, a loro volta convogliate in un armonioso ingorgo sinuoso e fluttuante che seduce e confonde: otto minuti in tutto, prodromo dell’arte varia di questo act dalle movenze imprevedibili, oscillanti tra l’elettronica provvidamente contemporanea di “Shell of Fears” ed il pop internazionale di “Down the fields”, tra le tentazioni meticce di “Vague à l'âme” e l’esaltante electropop forsennato di “Le grand carrousel”, lanciata a folle velocità tra echi di La Femme e Mano Negra.
Le voci maschile/femminile si alternano sottraendo certezze e punti di riferimento, gli strumenti si sovrappongono, si rubano la scena, si fondono nuovamente in fogge avulse dalla somma delle parti: è maestosa “Igor (take me far away”), scritta nel 2021, inizio disarmonico e attendista à la Dan Sartain, lungo break centrale guidato dalla chitarra in meandri reconditi, un crescendo non lineare che devia il brano altrove, prima della reprise finale. E’ una ridda di sorprese in ordine sparso, trucchi di scena, magheggi e divagazioni, dalla trasognata, estatica lullaby in spagnolo di “Anoche ayer” alle contorsioni quasi prog di “Questa non è una poesia”, fino all’accoppiata di chiusura – spiazzante, disallineata –, affidata a due episodi risalenti agli albori del gruppo. Cala il sipario sul morbido reggae strumentale di “Pink way”, ma soprattutto sui sette minuti di “Martin Eden”, invenzione di traboccante intensità che caracolla tra vocalizzi rarefatti, ricami del violoncello, synth saturi e feedback disturbato, suggello di un lavoro che disvela per gradi la propria sottile, preziosa magia. Nascosta, eppure imponente. (Manuel Maverna)