
WE ARE WINTER'S BLUE AND RADIANT CHILDREN "No more apocalypse father"
(2024 )
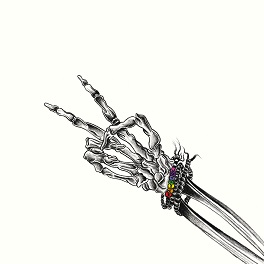 Non si può prescindere da Thierry Amar ed Efrim Menuck: lo scrivevo qualche anno fa su un noto social network, così ex abrupto, una mattina a caso, esprimendo un pensiero che mi veniva dal cuore. Un pensiero confermato e corroborato – sia ben chiaro - da evidenze incontrovertibili ed inconfutabili ogni volta che uno dei due pubblica qualcosa sotto qualsiasi sigla.
Non si può prescindere da Thierry Amar ed Efrim Menuck: lo scrivevo qualche anno fa su un noto social network, così ex abrupto, una mattina a caso, esprimendo un pensiero che mi veniva dal cuore. Un pensiero confermato e corroborato – sia ben chiaro - da evidenze incontrovertibili ed inconfutabili ogni volta che uno dei due pubblica qualcosa sotto qualsiasi sigla.
Avanti un’altra, appunto: il progetto del momento di Efrim Menuck – affiancato da Mat Ball (Big|Brave) e da Patch One e Jonathan Downs (Ada) - prende il nome di We Are Winter’s Blue And Radiant Children e realizza per Constellation le sei lunghe tracce di “No More Apocalypse Father”, quarantaquattro minuti densi come lava, traboccanti di quella stessa immutata intensità che da un quarto di secolo alberga nell’opera omnia di Godspeed You! Black Emperor e Thee Silver Mt. Zion, portata qui ad un livello forse ancora più intimo ed introspettivo.
Disco incentrato sull’osservare senza intervenire: senza poter intervenire o senza voler intervenire, è l’interrogativo lasciato risuonare – spoglio, sibillino – nell’aria pregna di suono & elettricità che permea e pervade composizioni sovraccariche all’inverosimile, come da inveterata tradizione. Che ad occupare ogni interstizio siano le chitarre o il synth, poco importa: in primo piano resta sempre e comunque l’ambivalenza del leitmotiv suggerito, il conflitto tutto interiore fra trovarsi al sicuro ed assistere all’apocalisse che va in scena là fuori, protetti nel proprio rifugio. Il tema si ripropone per il tramite di immagini vivide e pulsanti, viscerali e carnali, dal racconto di “Rats And Roses” in apertura (butterfly effect o mors tua vita mea?), con la voce che si inerpica su un registro à la Robert Smith (sic!), fino agli otto minuti della lullaby desolata di “(Goodnight) White Phosphorous”, che suggella l’album su una diafana aria à la Talk Talk mentre riflette con sorda afflizione – falsamente conciliante - sull’uso bellico delle bombe al fosforo bianco. Ossia, illuminare la notte inondandola di veleno: spettacolare e mortifero, come Hiroshima, in fondo.
Nel mezzo, le increspature à la Flying Saucer Attack – stordenti e astratte – di “Tremble Pour Light”, con testo steso su un tappeto di disturbi, eppure conturbante e straniante; il languore struggente di “Uncloudy Days”, affidata alla morbidezza infida del synth; i tredici minuti in crescendo di “Dangling Blanket From A Balcony (White Phosphorous)”, ispirata dall’agghiacciante immagine di Michael Jackson che sporge il figlioletto dal balcone di un hotel, brano che da quella insensata imprudenza muove, ricordando idealmente la scrittura dell’ultimo Mark Kozelek e ragionando sul senso delle cose, prima di collassare in una nebulosa di feedback; la title-track, stravolta e sporca, minacciosa e rimbombante, brutalizzata dall’ennesimo magma di distorsioni, trafitta da un canto lontano che sembra sì affogare, ma che rimane stentoreo, epico, quasi stoico nel dipingere a tinte fosche sfuggenti scenari di ordinaria desolazione.
Album totalmente libero dai confini della metrica o della ritmica, procede rigonfio di una mestizia melanconica, talvolta agonizzante, altrove soave; sullo sfondo, scorrono in non-ordinata sequenza le svariate piccolezze di una quotidianità che spaventa, col suo essere confortante da un lato, raggelante dall’altro, celebrazione e constatazione di un atavico senso di colpa, ricacciato indietro semplicemente chiudendo la finestra e continuando ad assistere allo show.
Non si può prescindere da Thierry Amar ed Efrim Menuck: lo penso tuttora, com’è logico che sia. (Manuel Maverna)